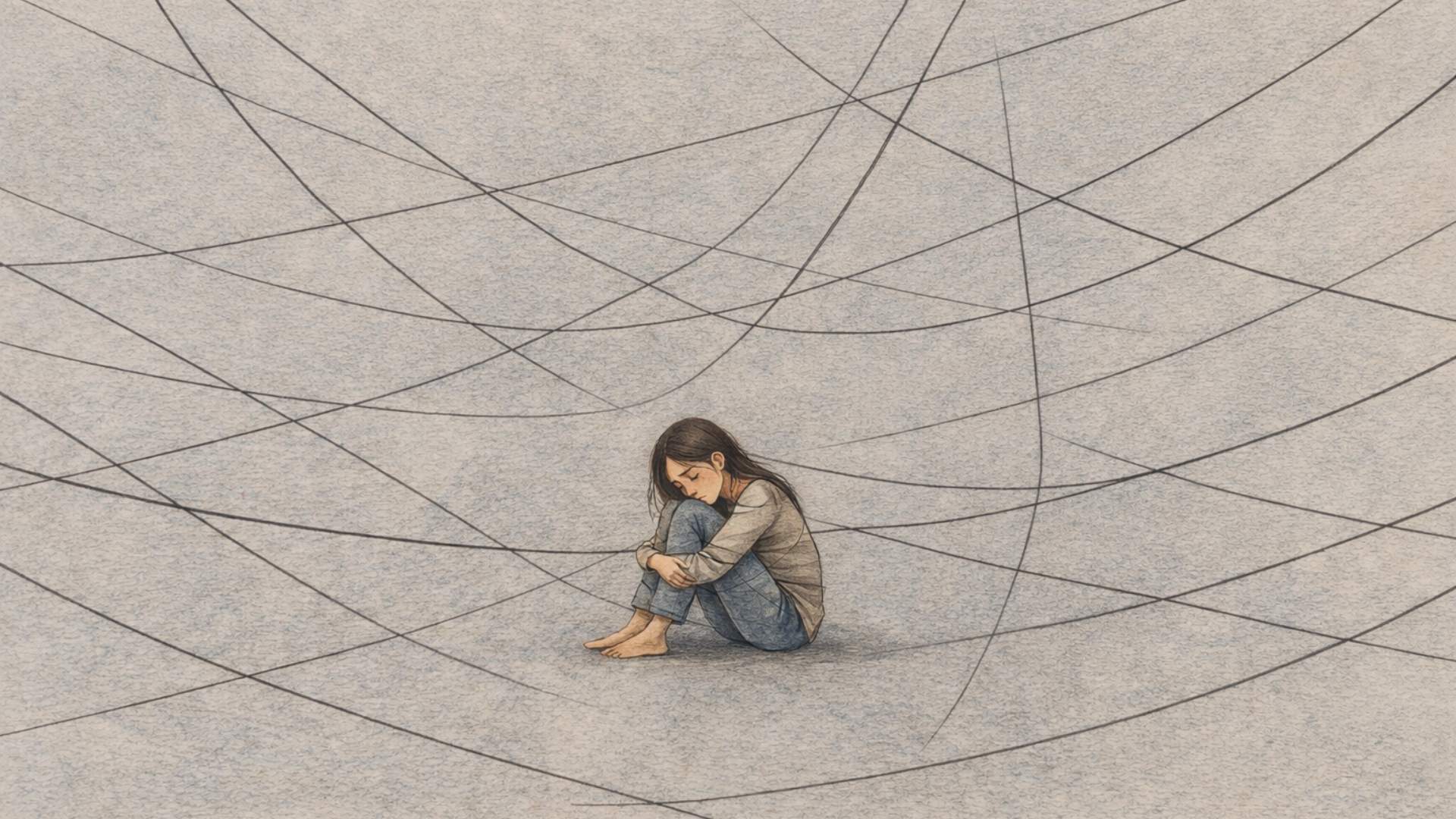La cattura di Nicolás Maduro da parte di forze statunitensi ha avuto un effetto prevedibile: prima ancora che emergessero dettagli verificabili, una parte consistente del dibattito pubblico globale aveva già deciso che cosa pensare. Gli Stati Uniti, ancora una volta, sarebbero intervenuti per imporre la legge del più forte, saccheggiare risorse naturali e violare il diritto internazionale, aprendo un pericoloso precedente che legittimerebbe future aggressioni da parte di Cina e Russia. In questa narrazione, Maduro diventa quasi un pretesto, un simbolo all’interno di una visione del mondo già preconfezionata in cui chi è e che cos'ha fatto semplicemente spariscono.
Questo riflesso automatico dice molto su chi lo attiva, che non si esprime per capire cosa stia accadendo, ma cerca di collocarsi moralmente rispetto a un “Occidente” percepito come intrinsecamente colpevole.
Questa visione appare distorta da più punti di vista.
Il primo, e più ricorrente, è l’idea che l’azione statunitense sia spiegabile quasi esclusivamente con il desiderio di appropriarsi delle risorse venezuelane, una lettura seducente perché semplice, ma anche una delle più fragili dal punto di vista analitico. Ridurre una scelta di politica estera ad alto rischio a un singolo movente economico significa ignorare come operano gli Stati in un sistema internazionale complesso. Che piaccia o meno, gli Stati agiscono non inseguendo un unico interesse, ma bilanciando simultaneamente sicurezza, credibilità, stabilità regionale, alleanze e costi politici interni ed esterni.
Il fatto che si scelga un’azione che comporta conseguenze diplomatiche e politiche significative suggerisce l’esistenza di un calcolo strategico molto più ampio, ignorato da chi preferisce una spiegazione moralmente rassicurante, una semplificazione al limite del propagandistico che serve a evitare il confronto con una realtà scomoda: la politica internazionale non è un’arena morale, ma un sistema competitivo in cui gli Stati cercano di minimizzare rischi e massimizzare sicurezza.
Un secondo equivoco riguarda la presunta arbitrarietà dell’azione statunitense. L’idea che il Presidente possa decidere interventi di questa portata in totale autonomia è profondamente radicata nel discorso pubblico, ma è smentita dalla realtà istituzionale americana. Il Congresso degli Stati Uniti, pur non intervenendo nel dettaglio operativo, esercita un ruolo decisivo attraverso autorizzazioni generali, finanziamenti, sanzioni e, soprattutto, attraverso il silenzio politico. La storia recente offre esempi eloquenti: Panama nel 1989, Afghanistan dopo l’11 settembre, Iraq nel 2003. In tutti questi casi, il Congresso ha scelto di non bloccare l’azione esecutiva, assumendosi una responsabilità politica indiretta.
Questo meccanismo di avallamento de facto non è una deviazione del sistema, è una sua caratteristica strutturale. Il potere legislativo accetta una certa discrezionalità esecutiva in cambio di rapidità decisionale e condivisione della responsabilità politica. Nel caso del Venezuela, l’assenza di una condanna formale o di un blocco legislativo non è un vuoto, è banalmente un segnale coerente con precedenti consolidati. Ignorare questo aspetto significa costruire una caricatura del sistema politico statunitense, utile solo alla polemica.
È a questo punto che emerge una delle affermazioni più insistenti: l’idea che l’azione contro Maduro crei un precedente che giustificherà future aggressioni di Cina e Russia, una tesi analiticamente debole, perché presuppone che gli Stati agiscano per imitazione normativa, come se osservassero il comportamento altrui per legittimare automaticamente le proprie azioni. La realtà è radicalmente diversa. Gli Stati non “copiano” interventi altrui; valutano costi e benefici concreti. La Russia non ha annesso la Crimea perché esisteva il Kosovo. Lo ha fatto perché ha valutato che i costi (sanzioni, isolamento parziale, tensioni diplomatiche) fossero inferiori ai benefici strategici percepiti. La Cina non deciderà il destino di Taiwan in base a ciò che accade in Venezuela, ma in base a equilibri militari nel Pacifico, rapporti economici globali e capacità di deterrenza statunitense.
Attribuire alle azioni statunitensi una responsabilità automatica per il comportamento futuro di altre potenze significa confondere la narrazione con la strategia ed è anche una delle più gravi distorsioni del dibattito contemporaneo.
E arriviamo al punto in cui il dibattito su Maduro diventa davvero rivelatore, quello sul diritto internazionale, evocato come un totem assoluto, rigido e incontestabile. Nella narrazione dominante, gli Stati Uniti violerebbero un sistema di norme che dovrebbe funzionare come una sorta di codice penale globale: chi trasgredisce è automaticamente colpevole, chi denuncia è automaticamente nel giusto, una rappresentazione profondamente distante dalla realtà storica e giuridica delle relazioni internazionali.
Come sappiamo, il diritto internazionale contemporaneo nasce dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale come progetto eminentemente politico prima ancora che giuridico. La Carta delle Nazioni Unite del 1945 è il tentativo dei vincitori di istituzionalizzare un ordine che riducesse la frequenza e la distruttività dei conflitti armati, non di eliminarli del tutto. Il divieto dell’uso della forza sancito dall’articolo 2(4) è il pilastro di questo sistema, ma non è mai stato concepito come una norma assoluta priva di eccezioni. La stessa Carta riconosce il diritto all’autodifesa e attribuisce al Consiglio di Sicurezza il potere di autorizzare l’uso della forza in presenza di minacce alla pace.
Già questo dovrebbe bastare a smontare l’idea di un diritto internazionale monolitico e immutabile. Ma la prassi storica lo rende ancora più evidente. Il diritto internazionale non dispone di un potere coercitivo centrale paragonabile a quello di uno Stato sovrano. Non esiste una polizia globale, non esiste un monopolio della forza, non esiste un meccanismo sanzionatorio automatico. La sua efficacia dipende dalla volontà politica degli Stati, dall’equilibrio di potere e dalla pressione multilaterale. Questo lo rende inevitabilmente flessibile, interpretabile, talvolta anche contraddittorio.
In questo senso ciò che è accaduto in Kosovo nel 1999 rappresenta uno spartiacque. L’intervento NATO è avvenuto senza un’esplicita autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, bloccata dal veto russo. Dal punto di vista strettamente giuridico, molti studiosi lo hanno definito illegale. Ma allo stesso tempo, una parte significativa della dottrina lo ha considerato legittimo sul piano morale e politico, perché finalizzato a prevenire violenze di massa contro la popolazione civile. Questa ambiguità (illegale ma legittimo) non è una contraddizione accidentale, è la manifestazione concreta del conflitto tra legalismo astratto e necessità politica.
La Libia nel 2011 complica ulteriormente il quadro. In quel caso, il Consiglio di Sicurezza aveva autorizzato l’uso della forza per proteggere i civili. Formalmente, il diritto internazionale era stato rispettato. Nella pratica, però, l’operazione si era poi trasformata in un intervento di cambio di regime. Questo episodio ha lasciato un segno profondo, soprattutto nella percezione di Russia e Cina, che da allora guardano con estrema diffidenza qualsiasi risoluzione umanitaria, temendo (non senza ragioni) che il linguaggio del diritto venga piegato a fini politici.
È in questo contesto che nasce la dottrina della Responsibility to Protect, che introduce un principio politico non trascurabile pur non essendo una norma vincolante né avendo modificato formalmente la Carta ONU: la sovranità non è un diritto assoluto, comporta invece responsabilità. Se uno Stato non è in grado o non è disposto a proteggere la propria popolazione da genocidi, crimini contro l’umanità o pulizie etniche, la comunità internazionale può intervenire. Questa dottrina rappresenta il tentativo di adattare il diritto internazionale a un mondo in cui le principali minacce non provengono più solo da guerre interstatali, ma anche da Stati che diventano predatori dei propri cittadini.
Qui emerge una verità che il dibattito su Maduro tende a rimuovere: il diritto internazionale non è stato progettato per funzionare in un mondo di autocrazie cooperative e regimi che rispettano le regole. È un sistema che vive di compromessi, eccezioni e adattamenti. Pretendere che venga applicato in modo rigido e meccanico, soprattutto quando attori autoritari lo violano sistematicamente, equivale a trasformarlo in uno strumento di paralisi. Un legalismo ingenuo, che ignora i rapporti di forza e le asimmetrie reali, finisce spesso per favorire chi le regole le infrange deliberatamente.
A questo punto e non per ultimo entra in gioco il tema del doppio standard occidentale. Sì, l’Occidente interpreta le regole in modo flessibile quando i propri interessi vitali sono in gioco. Sì, questo genera diffidenza e risentimento, ma ridurre questa dinamica a pura ipocrisia significa ignorare la struttura dell’ordine internazionale. L’ordine liberale è un ordine egemonico: produce norme, ma riflette anche rapporti di potere. Questo non lo rende una farsa, lo rende semplicemente un sistema imperfetto, storicamente situato.
Il vero errore è trasformare questa imperfezione in una licenza narrativa per l’equiparazione morale. Se “anche l’Occidente viola le regole”, allora ogni violazione diventa equivalente. Se il Kosovo è stato illegale, allora la Crimea diventa comprensibile. Se la Libia è stata un abuso, allora Taiwan è solo una questione interna cinese. Questo slittamento non è analisi: è relativismo strategico travestito da critica.
Gli Stati non operano in un tribunale morale, operano in un sistema competitivo. Il diritto internazionale funge sì da cornice, ma non da gabbia. È un linguaggio che legittima, delegittima, orienta, ma non determina automaticamente il comportamento.
Nel caso di Maduro, la critica che invoca il diritto internazionale come barriera assoluta ignora tutto questo. Ma soprattutto ignora una domanda fondamentale: cosa accade quando il rispetto integrale delle norme favorisce la sopravvivenza e la proliferazione di regimi che le violano sistematicamente? Non esiste una risposta semplice. Ed è proprio per questo che viene spesso evitata.
Non va poi dimenticato che, se il diritto internazionale è il linguaggio, le autocrazie ne sono oggi gli utilizzatori più opportunistici. È uno degli aspetti più paradossali (e meno discussi) del dibattito contemporaneo: i regimi che violano sistematicamente le norme internazionali sono spesso i più solerti nel richiamarle quando tornano utili. Russia, Cina, Iran, Venezuela invocano la sovranità, la non ingerenza e il principio di autodeterminazione non come valori universali, ma come strumenti difensivi selettivi. Il diritto internazionale diventa così una vuota arma retorica.
Questo uso strumentale non è un’anomalia, ma una strategia consapevole. Come ha osservato l’ex diplomatico nonché politologo Stephen Krasner, la sovranità è sempre stata “organizzata ipocrisia”, proclamata come principio inviolabile ma costantemente adattata alle convenienze del momento. Le autocrazie contemporanee sfruttano abilmente l’ordine giuridico internazionale perché sanno che l’Occidente, vincolato da una cultura legalistica e da un’opinione pubblica sensibile alla legittimità normativa, è particolarmente vulnerabile a questo tipo di pressione discorsiva.
Proprio per questo non dovremmo mai dimenticare che il rispetto formale delle regole, in un sistema asimmetrico, non è neutrale. Quando una parte le rispetta rigidamente e l’altra le viola sistematicamente, l’effetto netto è un riequilibrio a favore del trasgressore, il che non significa che ogni violazione sia giustificabile, né che il diritto internazionale sia un orpello inutile, significa riconoscere che il legalismo assoluto, sganciato dal contesto politico, può diventare una forma di complicità involontaria. Hannah Arendt, pur in un contesto diverso, aveva già colto questo rischio quando metteva in guardia contro l’illusione che norme astratte potessero sostituire il giudizio politico in situazioni eccezionali.
Il mondo reale, per sua natura, produce eccezioni, per le quali L’Occidente viene accusato di “trovare sempre eccezioni” per intervenire, rafforzando così lo stereotipo di un ordine internazionale a geometria variabile. L’accusa non è infondata sul piano descrittivo, ma lo è sul piano interpretativo essendo le eccezioni non il segno di un sistema arbitrario, bensì la prova della sua natura politica. La differenza fondamentale tra Occidente e autocrazie non sta nell’uso delle eccezioni, ma nel modo in cui vengono giustificate e contestate. Le democrazie liberali devono spiegare, difendere, razionalizzare le proprie azioni davanti a parlamenti, tribunali, media e opinione pubblica. Questo processo è imperfetto, spesso ipocrita, ma reale. Le autocrazie, al contrario, non devono rendere conto a nessuno. La legalità, per loro, è un velo da sollevare o abbassare a piacimento.
Nel caso del Venezuela, questa asimmetria emerge con chiarezza. Maduro non è semplicemente un leader scomodo per Washington; è il capo di un regime che ha sistematicamente svuotato le istituzioni, represso l’opposizione e trasformato lo Stato in uno strumento di sopravvivenza personale. Trattare la sua cattura come un episodio isolato di imperialismo americano significa rimuovere deliberatamente questo contesto, una rimozione funzionale a una narrazione che mira a schierarsi.
Questa dinamica è amplificata dal ruolo dei media e della percezione pubblica. Nel dibattito contemporaneo, l’anti-occidentalismo è diventato una forma di capitale simbolico e criticare gli Stati Uniti è un atto identitario. Serve a segnalare appartenenza a un campo morale percepito come più consapevole, più “critico”, più emancipato. Il risultato è una forma di pensiero binario che tradisce proprio ciò che pretende di difendere. Se tutto è imperialismo, nulla lo è davvero. Se ogni intervento occidentale è moralmente equivalente, allora scompare la distinzione tra chi tenta (goffamente, contraddittoriamente) di mantenere un ordine e chi lavora attivamente per smantellarlo, il che si traduce in una presa di posizione che favorisce lo status quo autoritario.
Il paradosso finale è che la critica radicale all’Occidente finisce spesso per rafforzare l’ordine che dice di combattere. Insistendo su una visione rigida e astorica del diritto internazionale, si chiede alle democrazie di auto-limitarsi in un contesto in cui altri attori non riconoscono alcun limite. È una richiesta che suona nobile, ma che nella pratica produce vulnerabilità. Come osservava Hedley Bull, l’ordine internazionale non è garantito dall’assenza di forza, ma dalla sua gestione.
Il caso Maduro in questo contesto non è un’eccezione scandalosa, è semmai un sintomo che rivela la difficoltà dell’Occidente nel difendere le proprie azioni senza cadere nella giustificazione ideologica, ma rivela anche l’incapacità di una parte del discorso critico di confrontarsi con il mondo così com’è, anziché come vorrebbe che fosse. Tra l’imperialismo caricaturale e il legalismo ingenuo esiste uno spazio di analisi che viene sistematicamente ignorato.
È in questo spazio che si gioca il futuro dell’ordine internazionale. Non quindi nella purezza delle norme, né nella forza bruta, ma nella capacità di riconoscere che il diritto senza potere è retorica, e il potere senza diritto è instabilità. Fingere che questa tensione non esista non la risolve. La rende solo più pericolosa.