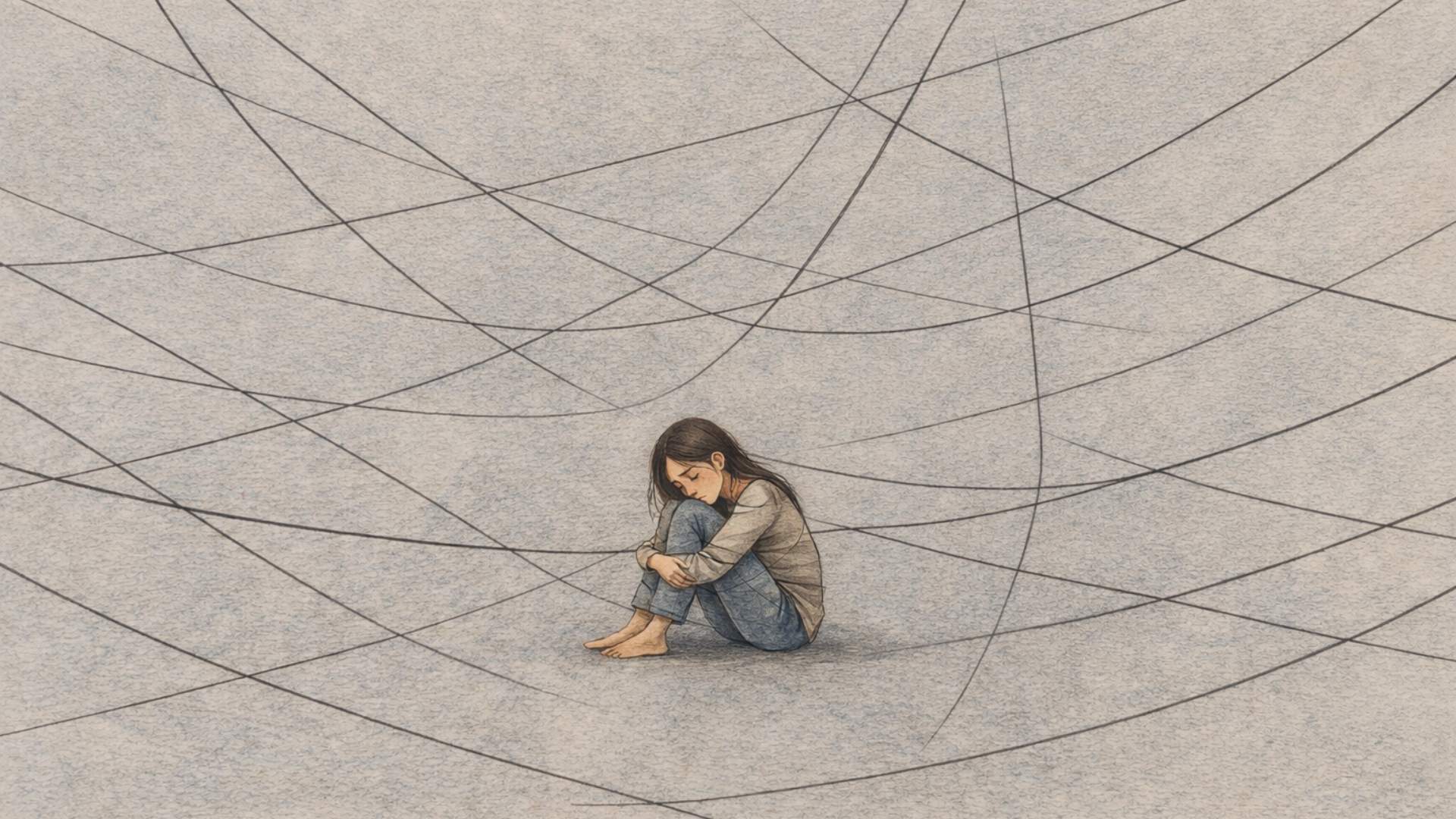1. Introduzione
L’ascesa del nazismo e l’attuazione della Shoah non furono il risultato dell’azione individuale di Hitler e dei suoi gerarchi. Al contrario, tali eventi rappresentarono la manifestazione estrema delle tendenze ideologiche già presenti e stratificate nella società tedesca, nella cultura e nelle sue istituzioni. In effetti, se tra le cause immediate possiamo trovare il fallimento del Sistema di Versailles del 1919-1920, la personalità carismatica dei leader nazisti e la crisi economica, l’origine dell’orrore nazista trova luogo più in profondità: l’antisemitismo, per esempio, fu una caratteristica della Germania già della seconda metà dell’Ottocento, soprattutto all'epoca di Guglielmo II, e caratterizzò il neonato ideale pangermanico.
Per comprendere la transizione verso il crimine più efferato perpetrato dai nazisti, il genocidio, è quindi necessario partire analizzando il rapporto storico tra lo Stato tedesco e la pratica dello sterminio nelle sue colonie, intese come veri e propri laboratori della violenza, per poi passare alla collaborazione nel genocidio degli armeni e arrivare alla Seconda guerra mondiale.

2. Il laboratorio coloniale in Namibia
All’inizio del ventesimo secolo, l’Impero tedesco esercitava la sovranità sull’attuale Namibia. In risposta all’insurrezione delle popolazioni herero e nama, Berlino adottò una strategia di eliminazione totale. Il generale Lothar von Trotha ordinò esplicitamente l’uccisione di ogni membro della comunità, senza distinzione di sesso o di età. Questo evento è classificato dalla storiografia contemporanea come il primo genocidio del Novecento, caratterizzato dal superamento della logica repressiva militare a favore di un progetto di sradicamento fisico dell’altro.
“Io, il grande Generale delle truppe germaniche, invio questa lettera al popolo herero. Gli herero non sono più sudditi tedeschi. Essi hanno ucciso e rubato, hanno tagliato orecchie, nasi e altre parti del corpo di soldati feriti e adesso, presi da vigliaccheria, non vogliono più combattere [...] All’interno dei confini tedeschi ogni herero, con o senza armi, verrà fucilato. Non risparmierò neppure donne e bambini”.
Nella campagna contro gli herero, la natura stessa venne trasformata in una variabile bellica letale. Dopo la battaglia di Waterberg (1904), i superstiti furono spinti forzatamente verso il deserto di Omaheke. L’esercito tedesco occupò sistematicamente i pozzi, utilizzando la privazione delle risorse idriche come arma di distruzione di massa. Tale gestione della scarsità indotta dimostra come il controllo delle risorse vitali sia stato uno dei primi esperimenti di gestione della morte di massa, un concetto che nelle scienze politiche contemporanee definisce la vulnerabilità dei gruppi sub-statali rispetto all'autorità centrale.
Chi sopravvisse alla privazione ambientale fu internato in campi di concentramento come quello di Shark Island (1905-1907). In questi siti, i prigionieri subirono non solo il lavoro forzato, ma anche esperimenti pseudoscientifici volti a convalidare presunte superiorità biologiche europee tramite la craniometria: il “dottor” Mengele non aveva inventato nulla di nuovo ad Auschwitz. In questi luoghi remoti vennero formalizzate le procedure di classificazione e deumanizzazione che, decenni dopo, avrebbero trovato un’applicazione industriale, chirurgica, in Europa. Si stima che l’80% della popolazione herero sia stata uccisa in questo periodo.
3. La complicità nel genocidio degli armeni
Durante la Prima guerra mondiale, la posizione dell’allora Germania rispetto al genocidio armeno operato dall'Impero ottomano rispose alle logiche di una pura realpolitik di origine bismarkiana. Nonostante la diplomazia tedesca fosse a conoscenza delle deportazioni e degli stermini, l’ambasciatore Hans von Wangenheim scelse l'indifferenza strategica per non compromettere l’alleanza militare con l’Impero ottomano. Dal punto di vista della disciplina delle Relazioni internazionali, questa scelta illustra come il primato degli interessi statali e della sicurezza a livello sistemico possa condurre alla normalizzazione dello sterminio agli occhi delle élite.
L'influenza di Berlino nel genocidio armeno fu anche dottrinale. Ufficiali come Colmar von der Goltz teorizzarono la deportazione di intere popolazioni come necessità strategica per la sicurezza interna secondo un approccio che trasformò civili innocenti in obiettivi legittimi, stabilendo un precedente per quella che, negli anni Novanta del ‘900, fu definita “pulizia etnica”. L’applicazione di logiche puramente militari alla gestione delle masse preparò il terreno per la successiva evoluzione della violenza burocratica.
4. La Shoah e l’industrializzazione dello sterminio
Con il regime nazista, il genocidio subì un processo di istituzionalizzazione senza precedenti. Nella Conferenza di Wannsee (1942), lo sterminio di sei milioni di ebrei fu pianificato come un’operazione aziendale e burocratica: a differenza dei massacri coloniali, per la Shoah vennero impiegate tecnologie specifiche, come le camere a gas di Auschwitz, per rendere la letalità rapida e sistematica, per rispondere a esigenze di efficientamento tipiche della logica aziendale. La violenza venne depurata dalla componente emozionale per trasformarsi in una fredda procedura d’ufficio, espressione della massima efficienza burocratica di uno Stato autoritario.
5. Il Porajmos e l’espansione del pregiudizio
La logica del genocidio e il razzismo tedesco non si limitarono all’uccisione sistemica delle comunità ebraiche tedesche e dei paesi invasi; altre popolazioni, soprattutto quelle slave e ungheresi, furono duramente colpite. In modo particolare (e più simile agli ebrei). Il genocidio coinvolse i popoli rom e sinti nel massacro denominato Porajmos. Centinaia di migliaia di individui furono vittime di sterminio o sterilizzazione forzata in quanto considerati una minaccia per la purezza ideologica dello Stato. Questa tragedia conferma che l’odio razziale, una volta istituzionalizzato, tende a espandersi verso ogni minoranza percepita come vulnerabile o non conforme ai canoni definiti dall’autorità.
6. Due approcci differenti
Quanto scritto finora si configura in quello che è l’approccio culturale di Daniel Goldhagen. Nel suo libro “I volenterosi carnefici di Hitler”, edito nel 1996, Goldhagen scosse il mondo accademico sostenendo che la Shoah non fu un’imposizione dall’alto, ma un vero e proprio progetto nazionale tedesco. Secondo la sua opinione, la cultura tedesca dell’Ottocento aveva interiorizzato un odio così radicale verso gli ebrei che la maggior parte dei cittadini era già psicologicamente “pronta” a ucciderli non appena lo Stato avesse dato il via libera.
Esiste comunque un approccio alternativo, quello di Hannah Arendt e di Christopher Browning. In particolare, seguendo il processo ad Adolf Eichmann nel 1961, la filosofa osservò che il gerarca nazista non era un “mostro” fanatico, ma un uomo mediocre, un burocrate pignolo che agiva senza riflettere sulle conseguenze morali delle proprie azioni. Per Arendt, il male nasce proprio dall’assenza di pensiero e dall’obbedienza cieca – in modo “banale”. Inoltre, Christopher Browning – nel suo libro “Uomini comuni (1992)”, studiò il 101° Battaglione di riserva della polizia tedesca (uomini di mezza età, non necessariamente nazisti convinti) che compì massacri in Polonia. Scoprì che a spingerli a sparare non fu l’ideologia in sé, ma la pressione del gruppo, cioè il desiderio di non sembrare “vigliacchi” o “deboli” davanti ai commilitoni, e il conformismo verso l’autorità. In questo modo, non solo la “preparazione” culturale fu un fattore rilevante, ma anche l’impersonalità della burocrazia e le spinte verso il conformismo sociale contribuirono a una delle più gravi tragedie dell’umanità. Questi approcci vanno visti come complementari l’uno all’altro.
7. Come reagirono gli attori in gioco all’Olocausto?
Le diverse condotte assunte dai protagonisti dello scontro tra il regime hitleriano e il popolo ebraico furono diverse. Il libro L’Olocausto (Engel, 2014) ci fornisce alcuni spunti.
Il primo attore era l’élite al potere nel Terzo Reich: per chi ne faceva parte lo sterminio sistematico degli ebrei non era solo un obiettivo politico, ma un imperativo etico assoluto. Secondo la loro dottrina, gli ebrei non venivano considerati esseri umani, bensì un pericoloso agente infettivo capace di portare l’umanità alla rovina. Questa percezione trasformò la persecuzione in una sorta di crociata spirituale, definita dagli storici “antisemitismo redentivo”. Per i capi del partito, quindi, l’eliminazione di massa rappresentava un fine prioritario, da portare a termine con determinazione, a prescindere dalle difficoltà logistiche o dalle necessità impellenti del fronte bellico.
Il coinvolgimento dei cittadini tedeschi e dei reparti operativi è al centro di una disputa storiografica che si divide principalmente in due correnti di pensiero e di cui abbiamo discusso nel precedente paragrafo. La prima pone l’accento su fattori psicologici universali, suggerendo che molti individui presero parte alle atrocità per ambizione personale, per non sentirsi esclusi dal gruppo o per un radicato rispetto verso l'autorità costituita. In questo scenario, la parcellizzazione del lavoro burocratico contribuì a far svanire la percezione della colpa individuale. La seconda corrente si focalizza invece sull’indottrinamento ideologico, sottolineando come la propaganda e l’istruzione scolastica avessero convinto la popolazione che la rimozione degli ebrei fosse necessaria per depurare la popolazione dalla contaminazione di quello che era considerato un vero e proprio virus che contagiava l’organismo tedesco. Sebbene una piccola parte dei tedeschi fosse animata da un fanatismo estremo, la maggioranza mantenne inizialmente un atteggiamento di indifferenza, accettando le prime leggi discriminatorie senza tuttavia prevedere l’orrore dello sterminio totale.

Il terzo attore era il popolo ebraico. L’atteggiamento dei perseguitati si trasformò radicalmente man mano che la violenza nazista diventava più oppressiva. In una prima fase dominò un profondo senso di incertezza, con molti ebrei tedeschi che interpretarono il nazismo come un fenomeno transitorio, sperando in un ritorno alla normalità democratica. Con il tempo, in effetti, si sviluppò una forma di resistenza spirituale attraverso la quale le comunità cercarono di preservare la propria identità culturale e religiosa per non soccombere moralmente. Nei ghetti dell’Europa orientale, alcuni dirigenti ebraici tentarono la via della salvezza attraverso il lavoro, cercando di rendere i prigionieri indispensabili per la produzione bellica tedesca; tale strategia portò a dilemmi etici irrisolvibili, come la selezione di alcuni membri per la deportazione nel tentativo di proteggere i restanti (decidere di deportare gli anziani già malati per evitare di deportare i bambini in salute). Infine, quando apparve chiaro che il destino era segnato, emersero movimenti di Resistenza armata che scelsero la battaglia non nella speranza di una vittoria, ma per salvaguardare la propria dignità.
Troviamo poi altri attori nei territori che si trovavano sotto l’influenza del Reich, e qui le reazioni furono variegate e frammentate. In diverse regioni dell’Est, come in Ucraina o in Lituania, si verificarono episodi di collaborazione e violenza locale, e parte della popolazione partecipò attivamente ai massacri per vecchi rancori o vantaggi personali. Altrove, invece, prevalse un sentimento di apatia: il destino degli ebrei veniva considerato un problema marginale rispetto alle fatiche quotidiane della guerra. Tuttavia, non mancarono esempi di opposizione e salvataggio: in paesi come la Danimarca o l’Italia, istituzioni e cittadini si adoperarono per nascondere i perseguitati e sabotare i piani di deportazione, dando vita alla categoria dei “Giusti fra le nazioni” che misero a repentaglio la propria incolumità per fini umanitari. Voglio qui ricordare la storia dell’Italiano in Ungheria Giorgio Perlasca, che si finse console spagnolo e salvò decine di migliaia di ebrei.
In ultimo, le potenze mondiali esterne al controllo nazista mantennero una condotta spesso caratterizzata da una tragica cautela. Inizialmente fu evidente la difficoltà nel credere alle testimonianze sui crimini in corso, poiché la brutalità descritta dai più fortunati che erano riusciti a sopravvivere e che avevano vissuto in prima persona quell’esperienza appariva inconcepibile per i canoni della civiltà contemporanea. Successivamente, i governi Alleati stabilirono che la priorità bellica avrebbe dovuto prevalere su tutto, ritenendo che solo una vittoria militare rapida potesse porre fine alle sofferenze, senza però deviare le risorse strategiche per missioni di soccorso specifiche. Infine, pesarono molto le restrizioni migratorie, con molti Stati che rifiutarono di accogliere i rifugiati a causa di timori economici o della volontà di non creare precedenti diplomatici complessi riguardo alle minoranze europee.
La rassegna qua proposta vuole dimostrare che l’Olocausto non fu un’anomalia improvvisa o un errore “storico”, ma l’esito di una convergenza tra ideologie preesistenti, sperimentazioni coloniali e strutture burocratiche moderne, nonché del conformismo e dell’indifferenza, e uesto è un punto fondamentale perché ci ricorda che de-umanizzare i nazisti è potenzialmente dannoso; essi erano umani, proprio come il popolo ebraico e come noi, quindi tutti, potenzialmente, potremmo essere capaci degli stessi crimini.